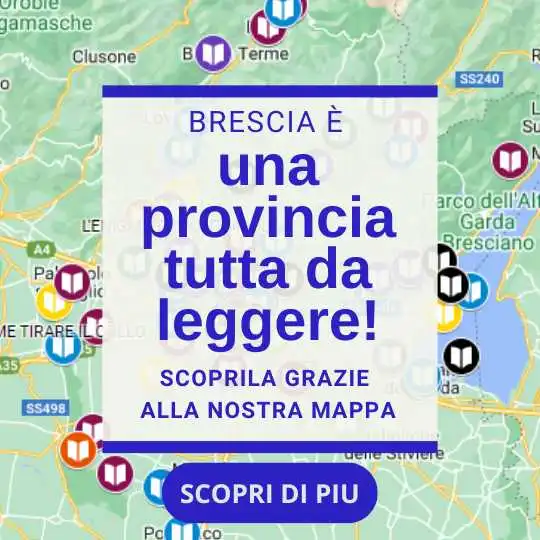“È questo che volevo?”: difficoltà e frustrazioni in una società a misura di maschio nel romanzo d’esordio di Mariagrazia Fontana

Letto e recensito da Candida Bertoli per Brescia si legge
Le storie di cinque donne, unite da uno stretto rapporto di amicizia che le lega fin dagli anni ’70 e da tormentate carriere in ambito medico, vissute tra gli alti e i bassi di vite professionali e personali condizionate dalle mille difficoltà che le donne incontrano in una società in cui le asimmetrie sono state e continuano a essere molto accentuate.
“È questo che volevo”, edito dall’editore ligure Temposospeso (2024), è il romanzo d’esordio di Mariagrazia Fontana, bresciana, già chirurga e medica d’emergenza nella sanità pubblica. Un romanzo corale, quello scritto da Fontana (già collaboratrice, tra le altre, di Secondorizzonte) che parla, attraverso i punti di vista e le vicende delle protagoniste, delle mille difficoltà aggiuntive che le donne lavoratrici sono costrette ad affrontare in una società costruita a misura di maschio, degli equilibrismi necessari e delle mille frustrazioni, ma anche la capacità di trovare la forza necessaria per affrontarle o per fare i conti con le conseguenze.
Cinque protagoniste diverse ma unite da un comune ‘destino’
Le cinque protagoniste del romanzo sono unite da un periodo di convivenza che risale agli anni ’70, anni durante i quali le donne hanno condiviso la casa a Pavia durante i sei anni di studio per conseguire la laurea in medicina. Dopo questa convivenza le vite delle protagoniste si separeranno, per tornare a avvicinarsi in età matura.
Dopo la laurea, Bianca diventerà infatti medica di base, Ester neurochirurga, Antonia patologa, Odilia odontoiatra e Pia psicoterapeuta. Ognuna di loro si costruirà una famiglia e una posizione professionale che si potrebbe definire di prestigio attraverso la professione medica. Ognuna di loro svilupperà una propria specificità, ma si ritroverà nel corso della sua vita a confrontarsi con una condizione condivisa e con alcuni temi comuni a tutte loro ed in generale a tutte le donne, dal professionale al personale.
Portare avanti una carriera tra pregiudizi e gender gap
Il primo tema che emerge dal racconto è quello della difficoltà che, spesso, le donne incontrano nel proprio percorso professionale, ostacolate da pregiudizi sociali, dall’egoismo dei familiari, dal non volere accettare compromessi o avances di carattere sessuale che con il lavoro non hanno nulla a che vedere. Le protagoniste del romanzo, senza svelare di più, si troveranno a fare i conti con questo tipo di difficoltà, che incideranno profondamente nella loro vita.
Il tema affrontato è trasversale ad ogni campo di attività femminile e non sicuramente circoscritto alla professione medica delle nostre cinque dottoresse poiché moltissime donne, ancora oggi, si sono trovate in situazioni di disagio o, più semplicemente, scavalcate dal collega maschio che, per esempio, difficilmente avrebbe chiesto un congedo per paternità. Occasioni che sfumano, possibilità improvvisamente negate o nascoste, ostacoli che si frappongono senza una ragione precisa, turni massacranti e perfidie sottotraccia sono aspetti della vita professionale che molte donne hanno trovato sul proprio percorso.
Il tema del lavoro è trasversale ad ognuna delle vicende delle nostre protagoniste: un lavoro affrontato con entusiasmo e caparbietà, ma che a volte assorbe ogni energia senza una corrispondente soddisfazione.
L’eccesso di burocrazia che porta il medico di base ad essere un dispensatore di ricette, il rapporto con alcuni pazienti arroganti, il senso di sfinimento derivante da ore e ore di lavoro e, di riflesso, le proprie vite che iniziano a vacillare: il tema della realizzazione professionale e dello stress e della frustrazione provocata, si intreccia infatti con quello dei rapporti familiari, in cui da un lato spesso ci sono mariti poco collaborativi se non addirittura ostili all’avanzamento e dall’altro c’è il tema della maternità.
Dal professionale al personale, dal privato al politico
Le cinque protagoniste affrontano sia il periodo dell’adolescenza dei figli, con le problematiche sottese quali l’anoressia e l’autolesionismo, sia quello del “nido vuoto”, quando i figli si allontanano e le case sembrano improvvisamente perdere ogni significato. Si tratta di momenti di vita che le segnano, così come loro stesse hanno dovuto affrontare, in precedenza, il rapporto con i propri genitori, il bisogno del distacco, i sensi di colpa, i riavvicinamenti in età matura.
“Mi mancano i ragazzi, Dio come mi mancano. Cosa penseranno della mail che ho inviato? magari credono che mi sono bevuta il cervello? A volte mi capita di sognarli, ma sempre bambini. Crescono in modo impercettibile i figli, in sordina e te li trovi adulti. Qui non mi sento sola, ma loro mi mancano, le loro risate, perfino le critiche acide da sapientini. Mi piacerebbe vederli, magari anche solo da lontano, scoprire come tiene i capelli Rachele, l’espressione di Lorenzo. Capirei tutto subito con uno sguardo, anche se ormai sono grandi e io non sono affatto necessaria. Ma indietro non si torna. Prima o poi però dovrò spiegarglielo che non prendo più la vita a testate, che non sono più la stessa persona di allora, impaziente, sempre sopraffatta dal dover essere, dal dover tenere insieme tutto. Che equilibrismi per noi in un mondo ostile alle donne.”
Mariagrazia Fontana, op. cit., pag. 191-192
Il tema della vecchiaia, della morte dei propri genitori e le riflessioni su come affrontare la propria è ancora un altro fil rouge che richiama l’attenzione delle nostre cinque donne, ormai al termine della carriera, e che si trovano a tirare le fila di un discorso antico.
“La morte. Non si tratta di ragionare tanto davanti alla morte, si tratta di ricordarsi di averla incontrata quasi annusata, e come sempre il quasi fa la differenza. Perché la morte si fa vedere, a volte si fa sentire proprio bene, ci butta lì delle specie di promo nel senso di vuoto che spesso compare sulla soglia del sonno, nell’angoscia del nero di una notte senza stelle. Si palesa sul volto degli altri, ma è la loro morte, nulla a che fare con noi. E non ci si può attrezzare, non ci si prepara a morire, si muore quando viene l’ora e basta. Si sta o di qua o di là, non c’è confine visibile anche a prezzo della peggior vertigine e non mitiga lo spaesamento il pensare che la vita porta in seno la morte.
– Che cosa ne sarà della vita quando smette di pulsare? Che fine farà l’energia di tutti quegli anni, quei dolori, quelle fatiche, quegli amori? – butta lì Odilia d’un fiato.
– Ma che cavolo di domanda. Quando non c’è risposta, la domanda è inutile. E’ una faccenda troppo complicata e non si arriva da nessuna parte – replica Antonia cercando di riportare il discorso in acque meno profonde. L’amica non le ha mai fatti questi discorsi.
– Sarebbe tutto più semplice, se si credesse in Dio. Morire in una sterpaglia, che destino senza pietà.”
Mariagrazia Fontana, op. cit., pag. 147
Le tematiche affrontate dalle interpreti del romanzo sono quelle con cui ognun* di noi si è trovat* a confrontarsi in uno o più momenti dell’esistenza, trovando la propria soluzione, il proprio percorso.
Consapevolezza e sorellanza le chiavi per superare le sfide
Per alcune di loro il rapporto con il cammino, con la montagna, con la natura, l’amore per un animale rappresentano vie praticabili, così come per Bianca lo è la scrittura:
“Del resto, non so se è poi vero che si scrive per essere letti. Forse in qualche strato non troppo profondo dell’inconscio c’è anche questa pulsione, ma non è questo il motore vero. Quando scrivo è come se trattenessi dentro di me la parola prima di farne segno, come se quel verbo o quell’aggettivo facessero da specchio al silenzio, dipanando la matassa per tirarne fuori il nocciolo duro, quello che conserva tracce della vita che l’attraversa, a volte fluida, a volte incespicante.
Ho smesso da tempo di scrivere per capire, anche se nei giorni fortunati, capita che scrivendo capisca qualcosina, quasi per caso, quello che in medicina si chiama un incidentaloma, cioè un riscontro occasionale che viene alla luce cercando altro. E’ come non fossi io ma fossero le parole stesse a farsi largo, a capire, quando mi si distendono nella mente e si sgranchiscono uscendo come d’incanto dal silenzio, luminose, del tutto libere da schemi.
Allora le frasi mi parlano, accendono luci fievoli che bastano a orientare il mio sguardo, suonano allarmi perché io faccia attenzione al treno in corsa.”
Mariagrazia Fontana, op. cit., pag. 161
Queste cinque donne, realizzate e inconcluse come tutti noi, sono legate da un fortissimo legame d’amicizia e solidarietà ed è forse proprio questa la chiave risolutiva di ogni dubbio e dolore: sapere di poter contare su chi c’è da sempre e ci sarà, senza giudicare. Le protagoniste del romanzo, pur con le proprie specificità e peculiarità, sembra che si fondano nell’archetipo del femminile, rappresentando le difficoltà che le donne incontrano quotidianamente e la forza necessaria per affrontarle, meglio se insieme, meglio se non da sole.

Titolo: E’ questo che volevo?
Autore: Mariagrazia Fontana
Editore: Temposospeso Editoria di resistenza, 2024
Genere: Narrativa
Pagine: 210
ISBN: 9791281467170
Incontrarci non è stato facile, ora non perdiamoci di vista! Iscriviti alla nostra newsletter per essere aggiornato su ciò che accade sulla “scena letteraria bresciana”