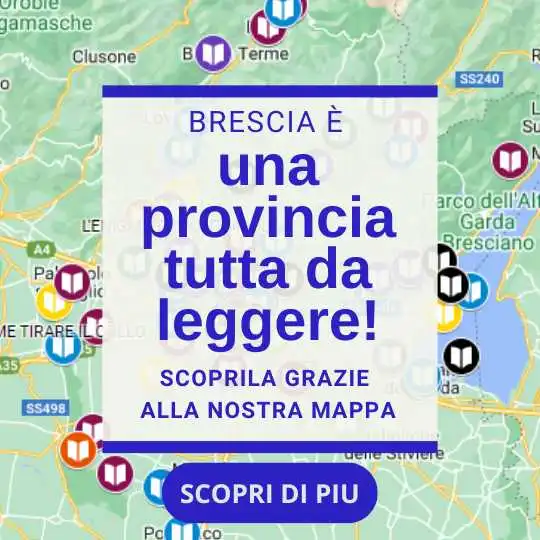“Le stanze dell’utopia – Massimo Castri e gli anni bresciani”: una monografia in due volumi sul regista che ha innovato la vita culturale di Brescia

Letto e recensito da Candida Bertoli per Brescia si legge
“Le stanze dell’utopia – Massimo Castri e gli anni bresciani” (La Quadra, in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano, 2024) è un’opera monografica splendida, dedicata a un uomo che è stato la storia del teatro italiano, il Regista con la maiuscola che ha contribuito con il suo lavoro a far nascere una nuova idea di spettacolo, di rapporto con gli attori e con il pubblico, a innovare radicalmente la vita culturale di una città ancora di provincia.
Ma andiamo con ordine. L’opera è composta da due volumi: il primo racconta gli anni in cui Castri arriva a Brescia e le vicende successive; il secondo è invece incentrato sulle produzioni realizzate dal maestro nei teatri bresciani, dal 1972 al 1993. Entrambi i volumi sono corredati da moltissime immagini: locandine, bozzetti, articoli di stampa, istantanee che riprendono il palcoscenico o i momenti delle prove, lettere professionali e personali, e tanti, tanti appunti annotati nei taccuini di lavoro, scritti con una grafia nitida e pulita, ma da cui emergono profondi spunti di una continua riflessione.
I primi cinque anni a Brescia (1971 – 1975)
Tanti, forse troppi, i tentativi di definizione: storicista – dialettico, idealista, marxista, illuminista, umanista, esistenzialista, freudiano, junghiano, strutturalista, formalista, realista… Aspetti che fanno parte del percorso di Castri e che nel tempo si sommano e mescolano in un cambio continuo di prospettiva e le cui tracce però convivono, concorrono al disegno generale. Castri è stato senza dubbio un poeta della scena anche per la volontà di portare al di fuori di sé ogni passo delle proprie visioni, per comunicare gli strati della sua complessità di approccio, ed ha portato avanti un percorso artistico che, se mette alla prova per rigore, coerenza e radicalità, però non esclude, ed è in cerca di un “tu”, di una risposta, di un confronto.
Thea Dellavalle, Le stanze dell’utopia – Massimo Castri e gli anni bresciani, vol. 1, pag. 44
Castri arriva a Brescia nel 1971 quasi per caso. Non ha ancora trent’anni e lavora come attore – scritturato dalla “Compagnia della Loggetta” – in “Scontri generali” di Scabia, di cui contesta tutto, dalle scelte metodologiche alle scene e ai costumi.
La Compagnia sta attraversando un momento difficile: la regista storica, Mina Mezzadri, si è allontanata e la mancanza di una figura significativa come è stata la sua è avvertita fortemente. Inoltre, è questo il momento in cui il Direttore artistico della Compagnia, Renato Borsoni, sta iniziando ad accarezzare un progetto visionario e ambizioso, quello cioè di trasformare la Compagnia in un ente finanziato pubblicamente, facendola riconoscere come teatro stabile pubblico. La Loggetta già da oltre dieci anni opera con le logiche di un teatro pubblico: progetta, organizza e produce teatro come servizio alla collettività, con un ruolo ben definito all’interno del sistema culturale cittadino e regionale.
È dunque un momento di grandi svolte, di scelte impegnative ma stimolanti; Borsoni ha un’intuizione: propone a Castri di fare il salto, di assumere la nuova veste di regista. Castri è indeciso, non è sicuro di voler intraprendere il nuovo percorso che gli viene offerto, ma dopo un periodo di riflessione accetta, dando l’avvio ad un sodalizio professionale ed umano che durerà per tutta la vita, tra distacchi e riavvicinamenti.
L’inizio della carriera da regista
È l’inizio di un’avventura, che Massimo Castri affronterà con l’estremo rigore dello studioso. Ogni spettacolo messo in scena è oggetto di approfondimento sotto ogni profilo che mette in luce gli aspetti nascosti e meno rassicuranti. Il copione viene analizzato con gli attori, lo studio dello spettacolo avviene non soltanto basandosi sul testo da portare in scena, ma anche attraverso la conoscenza analitica tanto dell’intera opera del suo autore quanto della tradizione critica depositata sul testo stesso.
La monografia ripercorre un periodo estremamente fecondo. Castri e Borsoni vogliono sperimentare una tipologia di teatro svincolata dai paludamenti borghesi: sovvertono le abitudini sonnacchiose del pubblico, allestiscono nuovi spazi scenici, nuove luci, nuovi ambienti. Il teatro dev’essere di radicamento, fatto con le comunità e per le comunità. A “I costruttori di imperi” di Boris Vian, messo in scena nel dicembre 1972, segue “Fate tacere quell’uomo! Arnaldo da Brescia. Storia di papi, imperatori, eretici”, realizzato nell’ottobre del 1973. Quest’ultimo spettacolo registra il tutto esaurito in ognuna delle quaranta repliche ed è la dimostrazione della crescita del regista, soprattutto per la sua capacità di direzione degli attori in un meccanismo complesso e articolato.
Nel 1974 nasce il Centro Teatrale Bresciano, voluto dal Comune e dalla provincia di Brescia, e la Compagnia della Loggetta ne fa parte dal mese di marzo 1975. Per la prima volta in Italia si assiste alla presa in carico della responsabilità di un centro di produzione teatrale da parte di Enti Locali, dando l’avvio a un progetto nuovo e inedito. I filoni di lavoro programmati sono quattro: classico, storico, di attività sul territorio ed infine di ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale bresciano, anche dialettale.
Castri ha portato in scena alcune opere di Brecht, tra cui “Un uomo è un uomo” e le “Operine”; vorrebbe proseguire, ma il progetto è ostacolato dai veti posti dal “Piccolo Teatro” di Milano e da Giorgio Strehler, che oppone alle richieste di Brescia i diritti sull’opera brechtiana detenuti da un’agenzia tedesca con cui il Piccolo intrattiene rapporti strettissimi.
La seconda fase: 1976-1981
Nell’arco di cinque stagioni Massimo Castri realizza, prodotto dal CTB, alcuni degli spettacoli più importanti della sua carriera, pietre miliari per la regia italiana del Novecento. Saranno caratterizzati da un inedito rapporto con il testo e con la scrittura, dal tentativo di portare nel teatro pubblico, nel discorso culturale più esteso, la forza di rottura della nell’ambito dei linguaggi che ha animato e anima i percorsi dell’avanguardia presto liquidata dal sistema come fenomeno a sé e relegata in categorie e percorsi identitariamente differenti. Sono otto spettacoli in cui la svolta di poetica prodotta dall’incontro con Pirandello si afferma, matura e si dispiega. Otto capitoli, otto frammenti di un “discorso amoroso” sul teatro (turbolento come solo l’amore può essere) che si arricchisce ad ogni passaggio costruendo un mondo poetico di segni personalissimi e capaci di scuotere e turbare il pubblico, un percorso che fluisce fino a una brusca battuta d’arresto.
Thea Dellavalle, Le stanze dell’utopia – Massimo Castri e gli anni bresciani, vol. 1, pag. 88
Dopo Pirandello e la nascita del sodalizio con Valeria Moriconi, Castri approda a Ibsen: “Rosmersholm” nel mese di marzo 1980, poi “Hedda Gabler” in ottobre, mentre nel contempo gli è frequentemente richiesto di tenere lezioni e seminari.
Ora però vuole tentare strade nuove, ed ecco nascere il progetto di “Caterina di Heilbronn”, di Kleist, previsto in cartellone per il mese di aprile dell’anno successivo. Lo spettacolo viene programmato, viene venduto per andare in scena in molti altri teatri, ma purtroppo il rodato meccanismo si inceppa. Le prove non vanno bene, il senso del ritardo è sempre più pressante, lo scenografo e l’assistente alla regia abbandonano. Castri chiede un rinvio ma non gli viene concesso a causa di vincoli progettuali e produttivi. Solo due dei cinque atti previsti vanno in scena e, prima di ogni replica, Borsoni esce sul proscenio per avvisare il pubblico che assisterà ad una sorta di work in progress.
Le conseguenze sono note: il bilancio del CTB è in dissesto, il pubblico è disorientato dalla visione di uno spezzone di spettacolo di difficile comprensione, è una débacle. Benché Castri riceva il premio UBU per la l’elaborazione drammaturgica, il suo rapporto con il CTB si interrompe e il Consiglio decide di sospenderne la progettualità. Al regista viene imposta una pausa di riflessione, durante la quale occuparsi della curatela di un secondo volume di taccuini dedicati agli spettacoli ibseniani e impegnarsi a un progetto per “Faust” di Goethe.

Gli anni successivi a Brescia
Dopo due anni di collaborazione con il “Piccolo” sia come docente che come regista, il rapporto con Brescia riprende. Massimo Castri però non è più il regista esclusivo del CTB, benché allestisca sei spettacoli importanti in cinque stagioni: spettacoli per cui riceverà premi prestigiosi come quello conferito dalla Biennale di Venezia per “Urfaust” e due premi UBU (“Il gabbiano”, miglior spettacolo, e “La famiglia Schroffenstein”, miglior regia).
È un Castri “seconda maniera” quello del 1985, che:
(…) abbandona l’approccio drammaturgicamente violento, i tagli, i sezionamenti, le riscritture e inizia una nuova fase di lavoro che aderisce al testo fedelmente, lavora di cesello nella cura della recitazione, e affida la lettura registica principalmente alla gestione dello spazio e del gesto scenografico.
Thea Dellavalle, Le stanze dell’utopia – Massimo Castri e gli anni bresciani, vol. 1, pag. 142
Il percorso di vita del CTB subisce un’ulteriore prova: nel 1988 Renato Borsoni si dimette dalla carica di Direttore artistico, come gesto di rifiuto per l’intromissione della politica nella linea culturale del teatro. Castri porta avanti altri spettacoli, ma l’armonia dei primi anni bresciani si è esaurita. L’ultima produzione sarà “Il gioco dell’amore e del caso” di Marivaux, portato in scena nel mese di marzo del 1993. Negli anni successivi lavorerà come libero professionista, affronterà nuovi autori, si confronterà con attori giovani.
E quando si ripresenterà la possibilità di “costruire teatro”, con la proposta di dirigere il “Metastasio” di Prato, Castri vorrà Borsoni al suo fianco, per condividere una nuova avventura, per riconfermare un sodalizio professionale ma soprattutto umano.

Gli spettacoli di Massimo Castri nei teatri bresciani
Ai ventitré spettacoli allestiti a Brescia con la regia di Massimo Castri sono dedicate le ulteriori 443 pagine del secondo volume della monografia, che si conclude con la corposa bibliografia, crediti e ringraziamenti.
Le schede riportano ogni dettaglio, regia, musiche, scena, personaggi ed interpreti, data del debutto e piazze di tournée. È rappresentata la locandina, ricostruita la rassegna stampa, riportate le fotografie della recita e, quando presenti, le note di regia.
“Le stanze dell’utopia” è un’opera in cui immergersi e, per chi l’ha vissuto, ritornare con il pensiero e il cuore a un periodo così intenso, vivace, stimolante per quella che ancora veniva definita la “città del tondino”. I testi parlano anche di teatro, forse soprattutto di teatro, ma di un teatro nuovo, vitale, controcorrente e a volte destabilizzante, sostenuto però da una città, da un fermento culturale e da un pubblico curioso, con spettacoli “sold out” per decine di repliche.
Un’utopia? Forse, senz’altro un’avventura irripetibile.

Titolo: Le stanze dell’utopia – Massimo Castri e gli anni bresciani (volume 1: Sguardi critici e testimonianze; Volume 2: Gli spettacoli)
Autori: AA.VV.
Curatori: Andrea Cora e Thea Dellavalle
Editore: La Quadra in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano, 2024
Genere: Saggio
Pagine: 409 (Volume 1) e 443 (Volume 2)
ISBN: 9788895251745
Incontrarci non è stato facile, ora non perdiamoci di vista! Iscriviti alla nostra newsletter per essere aggiornato su ciò che accade sulla “scena letteraria bresciana”