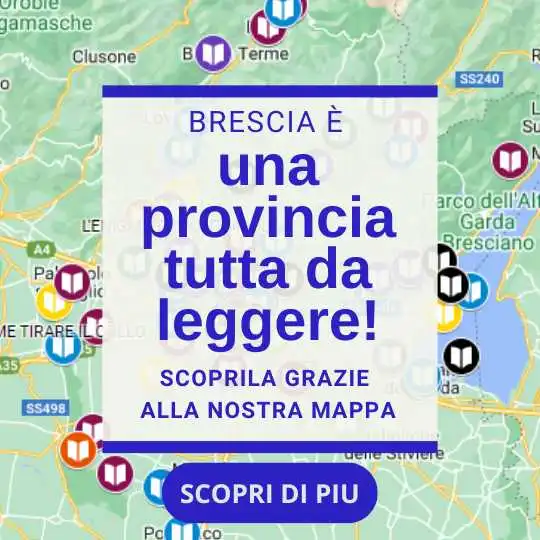“Vite da ariani”: un toccante romanzo storico racconta la vera storia dei Dalla Volta, una famiglia bresciana spezzata dalla Shoah

Letto e recensito da Francesca Scotti per Brescia si legge
Il romanzo di Guido Dalla Volta ricostruisce insomma la “caduta agli inferi” che travolse l’esistenza di migliaia di ebrei in Italia e milioni in Europa, Ma tratta anche della difficile, se non impossibile, ripresa della “normalità” per quanti sopravvissero nei decenni successivi al 1945. Un romanzo di testimonianza e memoria, dunque, ma la speranza è che possa essere anche un romanzo di formazione per quanti sapranno leggerlo, apprezzarlo, trarne lezione e monito.
Dalla prefazione di Liliana Segre a “Vite da ariani” di Guido Dalla Volta, p. 11
Chi passa in piazza Vittoria a Brescia potrebbe notare, rallentando il passo e abbassando lo sguardo davanti al portone del grattacielo ex torrione dell’Ina, numero civico 11, due piastrine rettangolari incastonate nel pavimento marmoreo. Sono le pietre d’inciampo che portano incisi i nomi di Guido Dalla Volta e di suo figlio Alberto, i quali hanno un tempo abitato proprio in un appartamento del grattacielo. Italiani, ebrei, Guido e Alberto sono stati arrestati dai fasciasti nel 1943, consegnati ai nazisti e infine deportati ad Auschwitz, da cui non hanno mai fatto ritorno.
Anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, un altro Guido Dalla Volta, nipote omonimo del nonno che non ha potuto conoscere, ritrova tra le pagine di un libro delle sorprendenti menzioni riguardo a un ventiduenne generoso e pieno di coraggio che nemmeno l’orrore del lager sembra aver potuto piegare. Il libro è “Se questo è un uomo” di Primo Levi”, il ragazzo è suo zio Alberto.
In “Vite da ariani” (Enrico Damiani Editore, 2024), Guido Dalla Volta sceglie la forma del romanzo per raccontare la storia del nonno, dello zio e di tutta la sua famiglia dalla Brescia dagli anni trenta fino ai giorni nostri, prima e dopo la Shoah, cucendo insieme passato e presente attraverso il filo indissolubile della memoria e componendo un libro tragico e coinvolgente che è insieme opera di narrativa, memoriale e testimonianza. Il testo è impreziosito da una prefazione a firma della senatrice Liliana Segre, oltre che da un’appendice con testi e lettere di Primo Levi.
Persecuzione e tribolazioni di una famiglia ebraica, nella Brescia del fascismo e della guerra
«A mio giudizio, ma, credetemi, è un giudizio che mi deriva da tante informazioni raccolte, è solo l’inizio. Prima o poi questa persecuzione farà un salto di qualità e passerà dai diritti civili alla libertà, se non peggio. Basta guardare cosa sta succedendo in casa del nostro alleato tedesco.»
Guido Dalla Volta, “Vite da ariani”, p. 218
Il piano temporale di “Vite da ariani” che si snoda negli anni trenta e quaranta dipinge, con ricchi dettagli storico-biografici, la tragedia che travolge la famiglia Dalla Volta, dalle prime restrizioni imposte dalle leggi razziali sino all’arresto e alla deportazione nei campi di sterminio di Guido e del figlio maggiore Alberto. Fatti e riferimenti storici si intrecciano ai pensieri e ai sentimenti dei protagonisti, in un vortice di orrori che paiono di volta in volta inattuabili e che invece, di volta in volta, si concretizzano e si ingigantiscono, oltre ogni peggiore previsione.
Nel 1938, Guido Dalla Volta e la moglie Emma vivono con i figli Alberto e Paolo nel cuore di Brescia, a pieno contatto con il brulicante mondo cittadino. Reduce della prima guerra mondiale, Guido dirige un consorzio chimico-farmaceutico insieme ad alcuni soci e si considera perfettamente integrato nella società del proprio tempo. Tutto inizia però a cambiare a novembre, quando le leggi razziali vengono legalizzate in Italia. Mentre Guido non pensa subito a una catastrofe – è fermamente convinto che esista una sostanziale differenza tra fascismo e nazismo e che, a ogni modo, il re Vittorio Emanuele III interverrà a tempo debito per impedire alla situazione di degenerare – Emma dimostra un sesto senso capace di fiutare la tempesta in arrivo.
Di capitolo in capitolo, seguiamo la disperata corsa contro il tempo di Guido, il quale, nel tentativo di proteggere la famiglia dagli effetti delle leggi razziali, rimane risucchiato in un lungo e logorante susseguirsi di carte, burocrazia e favori, un vortice kafkiano in cui nulla pare avere senso, se non la necessità di difendere la propria vita e quella di chi si ama. Nel suo intento incontra funzionari, ecclesiasti e comuni cittadini pronti ad aiutare lui e i suoi familiari, ma anche inaspettati delatori. Ed è infine proprio una serie di delazioni a vanificare i battesimi di convenienza e tutte le altre azioni attuate da Guido nel tentativo di sfuggire all’orrore. Una grave malattia contratta da Paolo, il minore dei fratelli Dalla Volta, permette a quest’ultimo e alla madre incaricata di assisterlo di sfuggire alla cattura e di essere successivamente aiutati a nascondersi, ma per Guido non c’è modo di sottrarsi all’arresto. Alberto, preallertato, potrebbe forse salvarsi, ma sceglie di restare accanto al padre e ne segue il tremendo destino.
Le pagine del libro che ricostruiscono questi fatti, dense di angoscia e di storia, prendono alla gola, indignano e, nonostante tutto, si leggono in un soffio perché vivide, intense, imbevute di dramma ma al contempo di coraggio e di testarda speranza, strabordanti, comunque e sempre, di vita.
La “colpa” dei salvati: la famiglia Dalla Volta dopo la Shoah
Così l’onda lunga di quei tragici eventi familiari colpiva anche un’altra generazione, ma lo faceva in modo subdolo, come un fantasma, del quale nessuno poteva e voleva riconoscere la presenza, e che, beffardo, induceva le proprie vittime a incolparsi a vicenda.
Guido Dalla Volta, “Vite da ariani”, p. 243
Alla vicenda degli anni trenta e quaranta si alterna un piano temporale che dalla fine della seconda guerra mondiale arriva fino ai giorni nostri. È il filone dedicato alla parte della famiglia Dalla Volta che, scampata alla crudele sorte di Guido e di Alberto, porta avanti la propria storia tra dolore e difficoltà. Ritroviamo così Emma, che sin dalla fine della guerra si sommerge di lavoro per riuscire a continuare a vivere, e Paolo, che il dramma vissuto in famiglia e la resistenza in Valtrompia hanno anzitempo trasformato in un adulto che porta in sé rabbia, volontà di riscatto, speranza e disperazione in ugual misura.
Proprio Paolo, il figlio sopravvissuto, è la figura più ricorrente di questi capitoli. Nel ricordo di un padre che idolatrava e di un fratello che non ha mai conosciuto abbastanza per via della differenza di età, Paolo vive gran parte dei suoi anni nel terrore che quanto accaduto possa ripetersi, nella diffidenza verso un paese che non l’ha difeso dal razzismo e dalla Shoah. Entrambi restii a raccontare del dramma cha ha spezzato la famiglia, Paolo ed Emma vivono, come recita il titolo del libro, “una vita da ariani”. Oppressi dal senso di colpa per essere scampati alla Shoah, cercano in ogni modo di vivere “arianizzando” i propri giorni, ricacciando dentro di sé il trauma innominabile di quanto accaduto, per evitare che possa continuare a recare dolore anche agli altri.
Prima di loro, anche Guido ha cercato di costruire per sé e per i suoi cari delle vite da ariani, ricorrendo a tutto quanto possibile per cancellare le proprie origini ebraiche e mostrare così la sua famiglia come ariana agli occhi di una società che ha deciso di annientare gli ebrei. Le vite da ariani di prima e dopo la Shoah si incontrano e si specchiano le une nelle altre e nei loro riflessi incrociati si compone e si consuma il dramma dei protagonisti.
Paolo si sposa e ha un figlio, il Guido autore del libro e che la nonna Emma non riesce a chiamare per nome. Un figlio che farà domande, che vorrà sapere, che oserà infrangere il tabù di un dolore inenarrabile – privato ma anche collettivo, perché quanto accaduto a loro è accaduto a migliaia di ebrei italiani, a milioni di ebrei europei – in nome della testimonianza e del dovere di fare memoria. Sarà lui a rompere il silenzio, a dedicarsi a una ricerca di anni che gli permette di fermare la vicenda della propria famiglia su carta, carta che può passare di mano in mano, salvando una storia e consegnandola ai posteri.
Le lettere di Primo Levi e altri documenti: una preziosa appendice
Un suo gesto, una sua parola, un suo rigo, avevano virtù liberatoria, erano un buco nel tessuto rigido del Lager, e tutti quelli che lo avvicinavano se ne accorgevano, anche coloro che non capivano la sua lingua. Credo che nessuno, in quel luogo, sia stato amato quanto lui.
Da “Il sistema periodico” di Primo Levi; brano riferito ad Alberto Dalla Volta e incluso nell’appendice di “Vite da ariani”, pp. 481-482
Nella preziosa appendice che chiude il libro, l’autore, insieme allo storico e attivista Marino Ruzzenenti (autore tra l’altro del più completo testo sulla persecuzione degli ebrei a Brescia durante la Shoah), ricostruisce tutto quanto possibile riguardo alla deportazione e alla morte di Guido Dalla Volta e di suo figlio Alberto, avvalendosi di alcuni documenti, ma soprattutto di vari passi tratti dalle opere di un grande scrittore, testimone e sopravvissuto della Shoah, Primo Levi, che nei giorni da internato nei lager ha stretto con Alberto una profonda amicizia.
Grazie a documenti provenienti dalla questura e dalla prefettura di Brescia, sappiamo che Guido e Alberto sono stati arrestati nel dicembre del 1943. Rinchiusi in un primo momento nel campo di transito di Fossoli, sono poi stati deportati, insieme a Levi e a innumerevoli altri, nel campo di sterminio di Auschwitz. Non si hanno notizie certe riguardo alla morte di Guido e di Alberto, ma tramite i dettagli riportati da Levi nei suoi resoconti della vita nel lager possiamo presumere che Guido sia morto ad Auschwitz verso la fine del 1944. Di Alberto, invece, si perde ogni traccia nel gennaio del 1945, quando, in vista dell’arrivo dell’Armata Rossa sovietica, lascia il campo perché costretto a prender parte alla mortale marcia di evacuazione ordinata dai nazisti in fuga. Levi, a differenza sua, resta nel campo in quanto ammalatosi di scarlattina e riesce così a salvarsi. È così proprio la scarlattina a dividere due amici e animi affini, Alberto Dalla Volta e Primo Levi, sceltisi come alleati nel mezzo dell’inferno.
Di Alberto, Levi parla in più occasioni con profondo affetto e incrollabile ammirazione, sia nei suoi libri che nelle due lettere indirizzate a Emma Dalla Volta incluse nell’appendice. In particolare, dai brani estratti da “Se questo è un uomo” e da “Il sistema periodico”, emerge un ritratto preciso e affascinante di Alberto, descritto come uno spirito libero che nemmeno il tragico destino toccatogli in sorte, le immani privazioni e il costante pericolo di morte possono annichilire.
È un’istantanea incorrotta quella che Levi ha sottratto ad Auschwitz e ci ha restituito. Rimane sotto gli occhi anche dopo aver smesso di leggere le sue parole. E Alberto ci appare davanti, irriducibile e vero, con il sorriso aperto e sereno delle foto di famiglia che brilla come una stella nelle tenebre che sono calate sulla sua giovinezza. È con questo sorriso, con questa luce, che termina un libro doloroso e necessario, difficile da non amare e impossibile da dimenticare, preziosa miniera di riflessioni, moniti e memorie per chiunque lo vorrà scoprire.
Se Alberto fosse tornato, non soltanto l’esistenza di Lei, signora, e dei suoi, ma anche la mia sarebbe certamente stata trasformata.
Dalla lettera di Primo Levi a Emma Dalla Volta del 20 dicembre 1945, inclusa nell’appendice di “Vite da ariani”, p. 497

Titolo: Vite da ariani
Autore: Guido Dalla Volta
Editore: Enrico Damiani Editore, 2024
Genere: Romanzo
Pagine: 512
ISBN: 9791254560518
Incontrarci non è stato facile, ora non perdiamoci di vista! Iscriviti alla nostra newsletter per essere aggiornato su ciò che accade sulla “scena letteraria bresciana”